Le classi possidenti che vivono del lavoro degli altri in ogni epoca storica si sono inventate le motivazioni per giustificare la loro condizione di parassiti privilegiati. Anche oggi in FCA avviene lo stesso: la colpa degli incidenti è degli operai.
Sempre gli oppressori hanno avuto l’esigenza di giustificare il proprio predominio sugli oppressi. Sostenere le ragioni della loro presunta superiorità non è un semplice esercizio di autoglorificazione ma serve a legittimare il loro dominio, a garantire che la sottomissione degli sfruttati non si fondi solo ed unicamente sulla forza, ma soprattutto sull’accettazione da parte degli oppressi della loro condizione di servitù. Marx sottolinea come “riconoscere i prodotti come propri e giudicare la separazione dalle condizioni della sua realizzazione come separazione indebita, forzata – è una coscienza enorme che è essa stessa il prodotto del modo di produzione fondato sul capitale, e suona la campana a morte per esso, allo stesso modo in cui la coscienza dello schiavo di non poter essere proprietà di un terzo, la sua coscienza in quanto persona, fa sì che la schiavitù sia ridotta a vegetare artificialmente e abbia cessato di poter sussistere come base della produzione”.
Ecco perché le classi superiori sono sempre tenacemente impegnate a convincere gli oppressi che la loro condizione di sfruttati è naturale e giusta. Ovviamente, mutando nei secoli le forme dello sfruttamento, il modo in cui si esplica il lavoro coatto, cambiano anche le giustificazioni che di questo fanno le classi superiori. Nel mondo antico, in cui prevaleva la schiavitù, il principale ideologo di questa sottomissione fu Aristotele, secondo cui “per natura esistono individui che sono liberi e altri che sono schiavi, per i quali la condizione di schiavitù è giovevole e giusta”. Per Aristotele, dunque, gli schiavi sono tali in quanto completamente privi della facoltà deliberativa, privi cioè di una volontà formata, di un dominio pieno di se stessi, incapaci di partecipare consapevolmente alla produzione del bene comune. Essi hanno bisogno della guida e del comando del padrone, che è, di contro, autosufficiente e cosciente del suo ruolo.
La concezione aristotelica della servitù per natura è la base comune di tutte le altre successive teorie che giustificano lo sfruttamento, che però hanno dovuto fare i conti ed adattarsi all’evolversi delle diverse forme di lavoro coatto. Questo sforzo di adattamento lo ritroviamo anche laddove si è avuta la necessità di “spiegare” il permanere di forme classiche di schiavitù ai margini delle nuove prevalenti forme di produzione. Nel Medioevo, ad es., dovendo fare i conti con i precetti della religione cristiana, che aveva espresso il passaggio dalla schiavitù alla servitù della gleba, proclamando l’uguaglianza di tutti gli uomini davanti a dio, il permanere della schiavitù viene giustificata da Agostino con l’eredità del peccato originale. Secondo lui “prima causa della schiavitù è il peccato per cui l’uomo viene sottomesso all’uomo con un legame di soggezione”. Un problema simile dovettero affrontare le classi dominanti molti secoli dopo, all’inizio dell’era moderna, in occasione della “Conquista” delle Americhe. Come giustificare, senza contraddire i dettami cristiani, la violenta sottomissione e riduzione in schiavitù dei nativi e la crescente importazione massiccia di schiavi dall’Africa nera? Juan Ginés de Sepùlveda risolve il problema sostenendo la “servidumbre natural de los indios”. Per costui gli amerindiani sono schiavi per natura, destinati ad obbedire a chi è loro superiore. Le atrocità della Conquista sono una punizione divina per i loro peccati, come fu quella di Sodoma e Gomorra. Essa è tesa non alla salvezza dei loro corpi ma a quella delle loro anime. Peggiore trattamento toccherà ai neri deportati con la forza nelle Americhe. Sulla presunta loro inferiorità naturale si pronunciarono in tanti, come Edward Long, che sostenne che i neri non appartenevano alla specie umana, ma ad una razza a mezza strada fra l’uomo e l’orangutan o lo stesso filosofo Locke, per cui la schiavitù dei neri era giusta perché “c’è tra alcuni uomini ed altri una distanza maggiore che tra alcuni uomini e le bestie”.
Ma se l’idea della servitù per natura è giustificazione sufficiente per la schiavitù classica, quando l’uomo è proprietà dell’altro, trattato come un qualsiasi strumento della produzione, essa diventa del tutto inadeguata a giustificare lo sfruttamento nella società capitalistica. Qui lo sfruttato, l’operaio, non si presenta come uno schiavo od un servo, ma come una persona libera che stipula col capitalista un “equo” contratto di compravendita. Il contratto è la forma giuridica che maschera la reale condizione di assoggettamento dell’operaio. Questi si presenta formalmente libero, in grado di scegliere a quale capitalista vendere la sua forza lavoro, ma in realtà, essendo privo delle condizioni di lavoro e di sopravvivenza, è comunque costretto a venderla ad un qualsiasi componente della classe dei capitalisti. Una volta venduta la sua capacità di lavoro, è costretto, per contratto, ad ubbidire ai comandi del capitalista, che lo fa lavorare molto di più di ciò che basterebbe a riprodurre il suo salario, che appare invece come retribuzione dell’intero lavoro operaio. Dichiarare allora, come per la schiavitù, che l’operaio e il capitalista sono tali per natura, che cioè la superiorità del secondo poggi sulla inferiorità per nascita del primo, sarebbe in contraddizione col presupposto del libero contratto fra persone giuridicamente uguali. Giustificare il dominio dei capitalisti diventa allora faccenda più complessa e difficile. Nella fase ascendente della borghesia l’ideologia che più fu adatta allo scopo è stata senz’altro quella protestante, in particolare di Calvino, per cui l’essere capaci di accumulare ricchezza era il segnale di essere eletti del signore, prescelti. Va da sé che, col progredire del capitalismo, una simile giustificazione ha mostrato la corda, sia perché l’ascendenza della religione è andata via via scemando, sia perché la stessa figura del capitalista che opera fianco a fianco con i suoi operai nella piccola officina è stata sostituita dalla figura dell’azionista e del manager nella grande industria. E’ rimasta ai capitalisti solo la possibilità di negare astutamente e con tenacia l’esistenza dello sfruttamento e al tempo stesso di giustificare il loro dominio con la favola del self-made man, l’uomo che raggiunge il successo grazie alle sue capacità. Il mito del sogno americano diventa il fragile velo con cui cercare di coprire la natura predatoria del capitalismo. Una giustificazione certamente fragile, destinata a vacillare ogni qualvolta le contraddizioni sociali manifestano i loro effetti. Ma quanto più diventa esile e debole la giustificazione ideologica del dominio delle classi superiori, tanto più si accentua la tenacia e la ferocia con cui esse tendono a sostenerne le ragioni. Potremmo parlare di una sorta di legge del contrappasso. Nel mantenimento della schiavitù e del servaggio giocano un ruolo importante fattori extraeconomici, quali ad es. l’esercizio della forza bruta, cui corrisponde una salda teoria di giustificazione del dominio, si è servi o signori per natura. Al contrario, nel caso della moderna schiavitù salariale, sono i fattori economici ad avere un ruolo preminente nella conservazione del dominio, in quanto è lo stesso corso economico a riprodurre costantemente da un lato i capitalisti e dall’altro gli operai, presentando così la sottomissione operaia come una oggettiva espressione di leggi naturali. A ciò corrisponde una giustificazione del dominio di stampo meritocratico, molto difficilmente accettabile da chi, nato povero, dopo aver sgobbato per un’intera esistenza, si ritrova sempre più povero. Ma è proprio questa intrinseca fragilità dell’impianto ideologico di giustificazione della superiorità degli oppressori a spingere i capitalisti a calcare la mano nel dileggiare e denigrare gli oppressi. L’ironia macabra e feroce serve appunto a sottolineare e rafforzare la loro presunta superiorità Accade così che nell’antichità, pur essendoci tanti esempi di efferati trattamenti riservati agli schiavi, sono poche le occasioni in cui essi erano dileggiati, come ad esempio col detto “Sardi venales, alius alio nequior” (Sardi in vendita e uno vale meno dell’altro), coniato in occasione della repressione di Gracco della rivolta dell’isola. Invece, nel capitalismo abbiamo moltissimi esempi di feroce ironia nei confronti degli oppressi. Non c’è dubbio che la casistica più emblematica di questa oscena galleria di frasi crudeli l’abbiamo col nazismo e non è un caso, dato che i lager funzionarono come un immenso bacino di mano d’opera quasi a costo zero per le imprese tedesche. Famoso è il motto che sovrasta il cancello di Auschwitz, “Arbeit macht frei” (il lavoro rende liberi), oppure quello simile all’ingresso di Dachau, “Jedem das seine” (a ciascuno il suo). Ma questa inclinazione canzonatoria è presente sempre tra i borghesi, anche in quelli contemporanei. A marzo 2019, l’amministratore delegato della Volkswagen, Herbert Diess, ha presentato un nuovo slogan per incitare a migliori prestazioni i dipendenti dell’azienda automobilistica: “Ebit macht frei” (il profitto rende liberi), che ricalca in pieno il motto nazista, della serie il lupo perde il pelo ma non il vizio …
In Italia non mancano esempi di questo tipo. Nel 2008, Marchionne cambiò il nome dello storico stabilimento Alfa Sud di Pomigliano d’Arco, con “Gian Battista Vico”. Il nome del grande filosofo, teorico dell’uomo artefice del proprio destino, dato ad una delle peggiori galere industriali moderne. “A ciascuno il suo” dicevano, appunto, le SS.
Vogliamo soffermarci però su un più recente esempio di questa attitudine padronale a dileggiare gli oppressi. Nell’infermeria dello stabilimento FCA di Melfi, ben in mostra, incollato alla parete, spicca il manifesto che riportiamo di seguito. Al centro di esso si legge, scritta in grande, la frase lapidaria: “Alcune persone non sono abituate a lavorare in un ambiente in cui è richiesta l’eccellenza”. Fanno da cornice ad essa una serie di vignette, ciascuna delle quali rappresenta un possibile incidente. Dalle vignette si capisce che l’intento è di attribuire la responsabilità di questi ipotetici incidenti agli operai stessi, colpevoli di comportamenti sbagliati, o distrazione, o mancata cura della pulizia della postazione, o fretta, o noncuranza dei segnali di avvertimento, ecc. Una delle vignette è particolarmente odiosa. Vi si rappresenta una operaia che si è fatta male perché, invece di indossare la tuta di ordinanza, si è presentata per pavoneggiarsi al lavoro con vestito lungo e tacchi a spillo. Riportiamo qui di seguito anche le singole vignette ingrandite. Vogliamo però nel merito fare due considerazioni. La prima è che l’infermeria è il luogo in cui, in genere, vengono fornite agli operai le prime cure nel caso di incidenti. Certo non deve essere bello per loro essere accolti subito in questo modo. L’azienda dice subito quale è il suo pensiero: se ti sei fatto male è colpa tua e questo mi dimostra che non sei “eccellente” come noi pretendiamo. A Napoli si dice cornuti e mazziati. La seconda è che questa versione aziendale sulla sicurezza in fabbrica è del tutto falsa, sia perché le norme di sicurezza degli impianti non riescono mai a rendere uguale a zero i rischi, sia perché le eventuali “distrazioni” non sono dovute a negligenza ma agli stessi eccessivi ritmi di lavoro, sia perché la stessa magistratura, restia in genere ad ascoltare le ragioni operaie, si è pronunciata in alcuni casi, sanzionando la responsabilità aziendale per degli incidenti. Si pensi alla condanna in Corte di Appello che la FCA di Melfi ha subito per l’incidente del 25 marzo 2008, che è costata la vita all’operaio Monopoli Domenico. I giudici hanno riconosciuto la condotta omissiva della suddetta azienda nella predisposizione delle misure di sicurezza imposte dalla legge.
A.V.










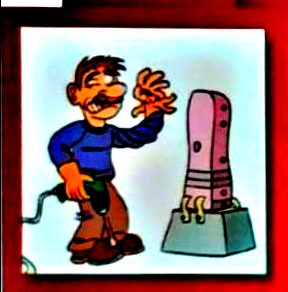
Comments Closed